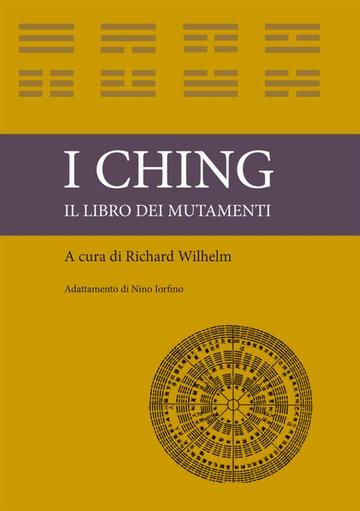Il rapporto tra Confucio (孔子, Kǒngzǐ, 551-479 a.C.) e l'I Ching (易經, Yìjīng, il "Classico dei Mutamenti") è una delle connessioni più profonde e influenti nella storia del pensiero cinese. Sebbene l'I Ching sia molto più antico del Maestro, è stata la sua adozione e reinterpretazione da parte della scuola confuciana a trasformarlo da un manuale di divinazione arcaico a un profondo testo di saggezza filosofica, etica e politica che ha modellato la civiltà cinese per millenni.
La tradizione e il dibattito storico: le "Dieci Ali"
La tradizione, consolidatasi soprattutto a partire dalla dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.) grazie allo storico Sima Qian, attribuisce a Confucio la paternità delle "Dieci Ali" (十翼, Shí Yì). Queste "ali" non sono parte del testo originale dell'I Ching (composto dai 64 esagrammi e dalle sentenze), ma sono una serie di sette commentari (suddivisi in dieci sezioni) che ne spiegano e approfondiscono il significato.
Tuttavia, il consenso accademico moderno è molto più cauto. Oggi si ritiene improbabile che Confucio abbia scritto personalmente le "Dieci Ali". L'analisi filologica e stilistica suggerisce che questi testi siano stati composti in un arco di tempo successivo, tra il IV e il III secolo a.C., da diversi autori appartenenti alla sua scuola di pensiero.
L'attribuzione a Confucio, quindi, non va intesa in senso letterale, ma come un modo per conferire la massima autorità a questa interpretazione. Legando i commentari al nome del "Primo Maestro", la scuola confuciana ha di fatto "canonizzato" il proprio modo di leggere l'I Ching, integrandolo nel cuore della propria dottrina.
La rivoluzione confuciana: dall'oracolo alla filosofia morale
L'importanza delle "Dieci Ali" è immensa perché segnano un cambiamento radicale nell'approccio al testo. Prima di esse, l'I Ching era principalmente uno strumento per la divinazione, usato per interrogare gli spiriti e prevedere il futuro. L'interpretazione confuciana, pur non negando la funzione oracolare, la subordina a un fine più elevato: la coltivazione morale dell'individuo e il buon governo dello Stato.
Questa nuova lettura, nota come la "Scuola del Significato e del Principio" (義理學, Yìlǐ Xué), si fonda su alcuni pilastri:
-
L'I Ching come specchio dell'ordine cosmico e morale: Per i confuciani, i mutamenti descritti dagli esagrammi non sono eventi casuali, ma riflessi del Tao, l'ordine naturale e morale dell'universo. Le leggi che governano il cosmo sono le stesse che devono governare la condotta umana e la società.
-
Il "Nobile" (君子, Jūnzǐ) come protagonista: L'intera interpretazione è orientata alla figura del jūnzǐ, l'uomo nobile, il gentiluomo, lo studioso-funzionario. L'I Ching diventa il suo manuale. Studiando le situazioni descritte dai 64 esagrammi, il nobile impara a riconoscere le dinamiche del presente, a comprendere le conseguenze delle sue azioni e ad agire in modo eticamente corretto e saggio. La domanda all'oracolo non è più "cosa mi accadrà?", ma "qual è l'azione giusta da intraprendere in questa situazione per rimanere in armonia con il Tao?".
-
Enfasi sull'etica e la responsabilità: Ogni esagramma e ogni linea mobile vengono letti in chiave etica. I commentari delle "Dieci Ali" introducono concetti chiave del confucianesimo come la benevolenza (仁, rén), la giustizia (義, yì), il rito (禮, lǐ) e la sincerità (誠, chéng). Il successo non è più una questione di fortuna, ma il risultato di un agire virtuoso e di una profonda comprensione delle circostanze.
-
Uno strumento per il buon governo: L'armonia della società è un riflesso dell'armonia cosmica. Un sovrano saggio, secondo questa visione, consulta l'I Ching per allineare le proprie decisioni politiche ai principi universali, garantendo così ordine, stabilità e benessere al popolo.
L'eredità duratura
La leggenda narra che Confucio, in età avanzata, disse: "Se potessi avere altri anni da vivere, ne dedicherei cinquanta allo studio dei Mutamenti, e allora potrei forse non commettere più errori gravi". Sebbene l'aneddoto sia probabilmente apocrifo, esso cattura perfettamente lo spirito dell'appropriazione confuciana dell'I Ching.
Grazie a questa fondamentale reinterpretazione, l'I Ching fu elevato al rango di Primo dei Cinque Classici del canone confuciano. Per secoli, la sua conoscenza (attraverso le lenti delle "Dieci Ali") fu obbligatoria per chiunque volesse superare gli esami imperiali e intraprendere la carriera di funzionario. In questo modo, l'etica e la cosmologia dell'I Ching confuciano non solo hanno influenzato la filosofia, ma hanno permeato la politica, l'arte, la letteratura e la struttura stessa della società cinese.