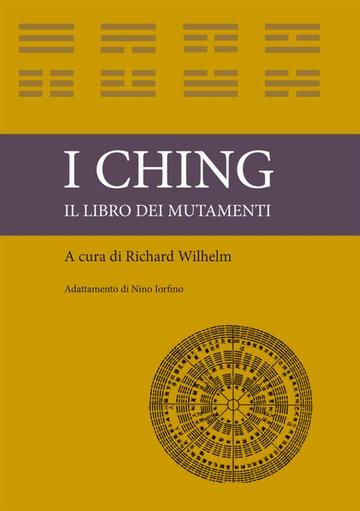La traduzione di Wilhelm, basata sull'edizione neoconfuciana Zhouyi Zhezhong, ebbe grande successo in Occidente anche perché il suo impianto etico e filosofico, incentrato sull'auto-perfezionamento, sull'ordine sociale e sulla figura del "nobile" (君子, jūnzǐ), presentava delle risonanze con la morale cristiana e l'umanesimo occidentale. Questo la rese più accessibile e "digeribile" per un pubblico non avvezzo alle sottigliezze del pensiero cinese.
Tuttavia, questa prospettiva, per quanto autorevole, è solo una delle grandi correnti interpretative dell'I Ching. L'approccio taoista offre una visione radicalmente diversa e, di conseguenza, muove critiche significative al modello confuciano utilizzato da Wilhelm.
Il Flusso cosmico e lo spazio vuoto
Mentre l'interpretazione confuciana (e quella di Wilhelm) si concentra sull'etica, sulla società e sullo sviluppo morale dell'individuo per agire correttamente nel mondo, l'interpretazione taoista si focalizza sulla cosmologia, sulla natura e sull'alchimia interiore.
Per i taoisti, l'I Ching non è primariamente un manuale di etica, ma una mappa del Tao: il flusso incessante, spontaneo e naturale dell'universo. Ecco i punti chiave della loro lettura:
-
Centralità del Non-Agire (無為, Wu Wei): A differenza del jūnzǐ confuciano, che studia i mutamenti per agire in modo efficace e virtuoso, il saggio taoista li osserva per allinearsi al loro flusso spontaneo. L'obiettivo non è "fare" la cosa giusta, ma non forzare il corso degli eventi, agendo in armonia con la corrente naturale delle cose. L'I Ching diventa uno strumento per percepire la direzione del flusso e lasciarsi trasportare, piuttosto che per dirigere attivamente il proprio destino.
-
Il Vuoto e la Ricettività: La tradizione taoista dà enorme importanza al concetto di "vuoto" (come il mozzo della ruota nel Tao Te Ching) e alla qualità dello Yin: la ricettività, l'oscurità, il femminile. Nell'I Ching, questo si traduce in una maggiore enfasi sulle linee spezzate (Yin) e sui trigrammi come K'un (坤, la Terra, il Ricettivo). La vera saggezza non sta nell'azione brillante dello Yang, ma nella capacità dello Yin di accogliere, nutrire e trasformare silenziosamente.
-
Alchimia interiore (內丹, Neidan): A partire dal periodo Han e soprattutto con la scuola della "Completa Realtà" (Quanzhen), i taoisti reinterpretarono l'I Ching come un manuale di alchimia interiore. I trigrammi e gli esagrammi non descrivono solo situazioni esterne, ma rappresentano energie e processi fisiologici e spirituali all'interno del corpo umano.
- I trigrammi Li (離, il Fuoco) e Kan (坎, l'Acqua), ad esempio, diventano simboli delle energie del cuore e dei reni.
- Il processo di trasformazione descritto dai mutamenti delle linee diventa una guida per "invertire il corso", raffinare il Jing (essenza vitale) in Qi (energia) e il Qi in Shen (spirito), con l'obiettivo di raggiungere l'immortalità o l'illuminazione. L'esagramma 11, T'ai (泰, la Pace), ad esempio, rappresenta la perfetta unione di Cielo e Terra nel microcosmo del praticante.
-
Critica del linguaggio e della morale: Il taoismo, specialmente quello di stampo zhuangziano, è scettico nei confronti delle rigide categorie morali e linguistiche. L'I Ching, in questa visione, non fornisce "giudizi" morali (fausto/nefasto in senso etico), ma descrizioni oggettive di una situazione energetica. "Fausto" (吉, jí) significa semplicemente che si è in armonia con il flusso attuale; "nefasto" (凶, xiōng) indica una disarmonia o un blocco che va compreso e assecondato, non necessariamente "corretto" con uno sforzo morale.
Le Critiche Taoiste alla Traduzione di Wilhelm
Partendo da queste premesse, le critiche degli esegeti taoisti (e di studiosi moderni che hanno riscoperto queste letture) alla versione di Wilhelm sono profonde:
-
Eccessiva "Confucianizzazione": La critica principale è che Wilhelm abbia presentato una scuola di pensiero, quella neoconfuciana di Cheng-Zhu, come se fosse l'I Ching stesso. La sua traduzione è intrisa di termini come "il nobile", "perseveranza", "riuscita", "colpa", che incanalano il testo verso un'interpretazione etica e finalistica, oscurando la sua natura più primordiale e cosmologica.
-
Mancanza della dimensione alchemica: La lettura taoista del Neidan è quasi completamente assente in Wilhelm. Egli menziona alcuni aspetti cosmologici, ma li interpreta sempre in chiave filosofica o psicologica (attraverso l'amicizia con Carl Jung), tralasciando la dimensione fisica e spirituale della pratica alchemica, che per molti taoisti era il vero cuore dell'insegnamento esoterico del libro.
-
Interpretazione Patriarcale e Solare: La scuola confuciana tende a valorizzare il principio Yang: il Cielo, il padre, il sovrano, l'azione. Wilhelm, riflettendo questa visione, mette in primo piano il ruolo creativo del Cielo (esagramma 1, Ch'ien, 乾). Una lettura taoista, invece, spesso sottolinea la superiorità del Ricettivo (esagramma 2, K'un, 坤), la "valle oscura" da cui tutto ha origine. Critici come il traduttore Thomas Cleary hanno evidenziato come le interpretazioni successive abbiano spesso "censurato" o ridimensionato la potenza del principio Yin, onnipresente nel testo originale.
-
Moralizzazione del fato: Traducendo "jí" e "xiōng" con connotazioni morali (propizio/nefasto, fortuna/sfortuna), Wilhelm lega l'esito di una situazione a un comportamento "corretto". Per un taoista, questo è un fraintendimento. Non si tratta di essere "buoni" per avere fortuna, ma di essere abili nel percepire la natura del tempo e agire di conseguenza. Anche una situazione "nefasta" può essere attraversata con maestria, senza giudizio morale.
In conclusione, se Wilhelm ha aperto le porte dell'I Ching all'Occidente fornendo una versione psicologicamente e filosoficamente ricca, le critiche taoiste ci ricordano che la sua è una mappa magnificamente dettagliata, ma di un solo versante della montagna. L'altro versante, quello taoista, offre una prospettiva più selvaggia, cosmica e interiore, meno interessata a costruire una società ordinata e più a danzare con il misterioso flusso del Tao.