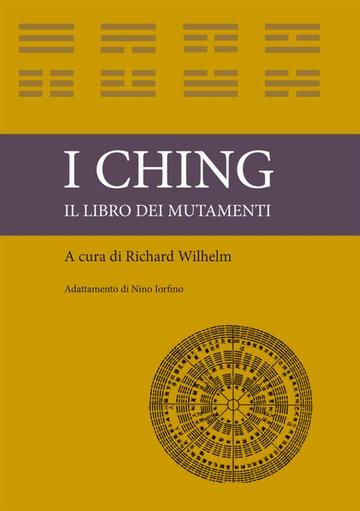Richard Wilhelm e l'I Ching: Un ponte tra Oriente e Occidente
Nel 2024 è ricorso il centenario della prima pubblicazione della traduzione dell'I Ching realizzata da Richard Wilhelm, un'opera che ha segnato profondamente la comprensione occidentale del classico oracolare cinese. Dalla sua prima edizione, pubblicata in Germania nel 1924 con il titolo "I Ging, Das Buch der Wandlungen", ha rappresentato un fondamentale ponte tra Oriente e Occidente, offrendo per la prima volta una versione accessibile e autorevole di questo antico testo. Grazie alla sua traduzione, Wilhelm ha reso disponibile all'Europa e al mondo un'opera che non è solo un sistema di divinazione, ma anche una guida alla saggezza e al cambiamento interiore. A distanza di un secolo, la sua eredità continua a influenzare studiosi, filosofi e praticanti dell'I Ching.

L'uomo e la sua missione
Richard Wilhelm, nato a Stoccarda nel 1873 e morto a Tubinga nel 1930, fu uno dei più importanti sinologi di lingua tedesca. Il suo percorso accademico iniziò con gli studi teologici a Tubinga, per poi approdare in Cina nel 1899, all'età di 26 anni, dove operò come missionario nella colonia tedesca di Kiao-Ciao (oggi Qingdao), nella provincia dello Shandong. Durante il suo soggiorno in Cina, Wilhelm si distinse per un approccio particolare alla sua missione: si fece addirittura vanto di non aver convertito alcun cinese al Vangelo, dedicandosi invece allo studio approfondito della cultura locale, un atteggiamento molto controcorrente per l'epoca.
Wilhelm rifiutò decisamente la visione eurocentrica della cultura cinese, nutrendo per questa una profonda ammirazione e impegnandosi attivamente per sviluppare un autentico scambio culturale. Questa posizione lo portò a ritirarsi progressivamente dall'attività missionaria per dedicarsi completamente alla sinologia.
Il suo lavoro di promozione della cultura classica cinese, svolto attraverso l'insegnamento accademico, le traduzioni e i contatti con importanti intellettuali dell'epoca, ha contribuito in modo significativo a una maggiore comprensione e apprezzamento della saggezza cinese in Occidente.
L'arrivo in Cina
Quando Wilhelm giunse a Qingdao nel 1899, la città si trovava sotto il controllo tedesco, essendo stata acquisita nel 1898 come concessione coloniale dalla Germania, che aveva ottenuto un affitto di 99 anni sulla baia di Jiaozhou. Questo avvenne nel contesto dell'espansione imperialista delle potenze europee in Cina, in seguito all'incidente del 1897 in cui due missionari tedeschi furono uccisi nella regione dello Shandong, dando alla Germania il pretesto per richiedere un territorio come risarcimento.

Dal punto di vista economico, Qingdao era in rapida trasformazione sotto il dominio tedesco. L'amministrazione coloniale avviò un ambizioso programma di modernizzazione, costruendo infrastrutture, ferrovie e un porto strategico. La città divenne un centro di commercio e un punto di accesso privilegiato per l'influenza tedesca in Cina. Tuttavia, il controllo coloniale tedesco non fu privo di tensioni, poiché la popolazione locale si trovò spesso emarginata rispetto ai privilegi concessi agli europei.
Dal punto di vista culturale, Qingdao era una città in fermento, con un crescente scambio tra cinesi ed europei. Le autorità tedesche incentivarono l'apertura di scuole e istituzioni culturali, con l'obiettivo di diffondere l'influenza occidentale. Fu in questo contesto che Wilhelm ebbe l'opportunità di immergersi profondamente nella cultura cinese, studiandone la lingua e i testi classici, e costruendo relazioni con intellettuali locali.
L'arrivo in Cina rappresentò per Wilhelm un vero e proprio punto di svolta. Giunto inizialmente con l'obiettivo di diffondere la religione cristiana, si rese presto conto che il vero valore della sua esperienza non sarebbe stato nella conversione dei cinesi, ma nella comprensione della loro cultura millenaria. Affascinato dalla filosofia e dalla letteratura cinese, iniziò a studiare intensamente la lingua e i testi classici, costruendo relazioni significative con intellettuali locali. Fu grazie a questo approccio aperto e rispettoso che guadagnò la stima della comunità cinese e poté accedere a insegnamenti che pochi occidentali avevano mai avuto l'opportunità di approfondire.
Nel corso della sua permanenza in Cina, Wilhelm studiò approfonditamente i classici della letteratura cinese, perfezionando la sua conoscenza della cultura e della storia locale. Questo percorso lo portò a diventare un riconosciuto esperto della materia, tanto che l'imperatore cinese gli conferì il "distintivo di quarta classe" legato al titolo "Dautai" per i suoi meriti nel campo dell'educazione. La sua profonda immersione nella cultura cinese fu determinante per il suo successivo lavoro di traduzione dei testi classici.
Lao Nai-hsüan e la Tradizione Confuciana
Dopo la caduta della dinastia Qing nel 1911 e l'instaurazione della Repubblica di Cina, molti studiosi confuciani tradizionali persero le loro posizioni ufficiali e si rifugiarono in luoghi più sicuri o culturalmente favorevoli. Qingdao, sotto il controllo tedesco dal 1898, divenne un punto di incontro per intellettuali in cerca di stabilità e opportunità di insegnamento. Lao Nai-hsüan (勞乃宣) trovò in Qingdao un ambiente relativamente protetto dove poter continuare i suoi studi e l'insegnamento della tradizione confuciana, lontano dai disordini della rivoluzione e dalla modernizzazione forzata che stava trasformando il sistema educativo cinese.

Fu in questo contesto che Lao Nai-hsüan incontrò Richard Wilhelm, con il quale instaurò una collaborazione fruttuosa e determinante per la traduzione dell'I Ching. Lao Nai-hsüan era un erudito confuciano di grande prestigio, che svolse un ruolo cruciale nel percorso di Wilhelm di approfondimento della cultura cinese. Era un profondo conoscitore dei classici e un esponente della scuola tradizionalista, che vedeva nei testi confuciani non solo un'eredità culturale, ma un codice di valori imprescindibile per il buon governo e l'armonia sociale.
Lao Nai-hsüan fu per Wilhelm non solo una guida, ma un vero e proprio maestro. Sotto la sua direzione, Wilhelm poté affrontare lo studio dell'I Ching secondo le prospettive autentiche della tradizione cinese, senza le distorsioni dell'interpretazione occidentale. Lao lo aiutò a comprendere il valore simbolico e filosofico del testo, trasmettendogli una visione profondamente radicata nella mentalità cinese.
Wilhelm iniziò il lavoro di traduzione nel 1913 e lo portò avanti con l'aiuto di Lao Nai-hsüan fino alla Prima Guerra Mondiale, quando il progetto subì un'interruzione. Riprese il lavoro nel 1916, completandolo dopo quasi dieci anni di intenso studio e confronto con la tradizione cinese. Il risultato fu pubblicato nel 1924, coronando il suo impegno nel rendere accessibile il testo al pubblico occidentale. Tuttavia, Lao Nai-hsüan non riuscì a vedere l'opera finita, poiché morì nel 1921, tre anni prima della pubblicazione. Il suo contributo fu comunque determinante per la realizzazione dell'opera, fornendo a Wilhelm una lettura che rispettava le interpretazioni classiche e gli strumenti per tradurre il testo in modo fedele e coerente con la tradizione. Questa interazione tra maestro e allievo fu essenziale per la qualità della traduzione di Wilhelm, che divenne un punto di riferimento per la cultura occidentale.
La traduzione come intermediazione culturale
Richard Wilhelm si dedicò alla traduzione di diversi classici della letteratura e della filosofia cinese. Prima dell'I Ching, aveva già tradotto: lo Zhuangzi, il classico daoista attribuito a Zhuang Zhou; il Tao Te Ching, la celebre opera di Laozi; e i Dialoghi di Confucio (Lunyu), uno dei testi fondamentali del confucianesimo.
Uno dei lavori più significativi di Wilhelm, successivo alla traduzione dell'I Ching, fu "Il Segreto del Fiore d'Oro" (Das Geheimnis der Goldenen Blüte), pubblicato nel 1929. Questo testo è un antico trattato taoista sulla meditazione e l'alchimia interiore, che Wilhelm tradusse e commentò con il contributo di Carl Gustav Jung. L'opera rappresenta una sintesi tra il pensiero cinese e la psicologia analitica junghiana, favorendo una comprensione più profonda delle pratiche spirituali cinesi attraverso una prospettiva occidentale.
La traduzione dell'I Ching rappresenta però il contributo più significativo di Wilhelm alla promozione della cultura cinese in Occidente. Questo lavoro non fu una semplice traduzione linguistica, ma un vero e proprio ponte culturale che permise ai lettori occidentali di accedere non solo al testo, ma anche allo spirito dell'antica saggezza cinese.
Come notato da Carl Gustav Jung nella sua introduzione all'edizione inglese: "L'I Ching non si fa avanti con dimostrazioni e risultati, non fa l'imbonitore di se stesso, né è facile avvicinarglisi. Quasi fosse una parte della natura, aspetta di essere scoperto". Questa osservazione riflette perfettamente l'approccio di Wilhelm: rispettoso, paziente e non invasivo.

Nel 1924 l'edizione tedesca dell'I Ching di Richard Wilhelm fu pubblicata dalla casa editrice Eugen Diederichs Verlag, con sede a Jena. Eugen Diederichs, editore e fondatore della casa editrice omonima, era noto per il suo interesse verso la filosofia orientale, la mistica e i testi esoterici. La sua casa editrice svolse un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura cinese e orientale in Germania e in Europa, contribuendo alla ricezione dell'I Ching come opera non solo divinatoria, ma anche filosofica e spirituale. La pubblicazione dell'opera di Wilhelm rientrava in un più ampio progetto editoriale volto a portare all'attenzione del pubblico occidentale i grandi classici delle culture asiatiche.
L'opera divenne un fenomeno globale quando fu tradotta in inglese da Cary F. Baynes, collaboratrice di Carl Gustav Jung, e pubblicata nel 1950 dalla Princeton University Press con il titolo "I Ching, The Book of Changes". La pubblicazione fu finanziata dalla Bollingen Foundation, un'organizzazione dedicata alla diffusione del pensiero di Carl Gustav Jung e alla promozione di opere fondamentali della cultura e della spiritualità mondiale. L'inclusione dell'I Ching nella Bollingen Series contribuì significativamente alla sua diffusione nel mondo occidentale e alla sua ricezione come testo non solo divinatorio, ma anche filosofico e psicologico.

Nel 1949, in preparazione dell'edizione inglese dell'I Ching, Carl Gustav Jung redasse una prefazione destinata a diventare fondamentale per la ricezione di quest'opera in Occidente. Il testo, pubblicato nell'edizione curata da Cary F. Baynes nel 1950, rappresentò un punto di svolta nella comprensione occidentale di questo antico classico cinese.
Nella sua prefazione, Jung presentò l'I Ching come un metodo per esplorare le connessioni tra eventi apparentemente casuali, ponendolo in deliberata contrapposizione al paradigma scientifico occidentale basato sulla causalità. Il celebre psicoanalista non si limitò a teorizzare: sperimentò personalmente l'I Ching, trovandovi conferme empiriche della sua teoria della sincronicità e suggerendo che il testo potesse offrire risposte profonde a chi vi si accostava con un atteggiamento aperto e contemplativo.
L'introduzione junghiana esercitò un'influenza determinante sulla diffusione dell'I Ching tra intellettuali occidentali come Octavio Paz, Philip K. Dick, John Cage, Bob Dylan, George Harrison e Allen Ginsberg. Grazie al contributo di Jung, l'antico testo cinese si affermò non solo come strumento divinatorio, ma come potente mezzo di introspezione psicologica e indagine filosofica. Paradossalmente, questo approccio psicologico alla lettura dell'I Ching, sviluppato nel moderno Occidente, avrebbe successivamente influenzato anche la stessa Cina, creando un affascinante dialogo interculturale tra tradizioni diverse.

All'interno di un più ampio interesse per la spiritualità orientale che contraddistingueva l'epoca, l'I Ching assunse anche un ruolo significativo nella cultura hippie degli anni '60. La sua filosofia, incentrata sulla natura mutevole della vita e sull'importanza dell'adattamento, si armonizzava perfettamente con gli ideali di libertà e spiritualità che caratterizzavano il movimento. Molti hippie utilizzavano l'I Ching come strumento divinatorio, lanciando monetine per ottenere risposte a domande sulla vita e sul futuro. Questo uso rifletteva la ricerca di significato e di connessione con qualcosa di più grande di sé stessi. Questo interesse contribuì a diffondere l'I Ching al di fuori dei circoli accademici, rendendolo un testo popolare nella cultura occidentale.
Oltre all'edizione inglese, l'I Ching del Wilhelm fu tradotto in numerose altre lingue, tra cui il francese, lo spagnolo e il russo, raggiungendo un pubblico sempre più vasto. In Italia, la versione di Wilhelm fu pubblicata nel 1950 dall'editore Ubaldini-Astrolabio nella collana diretta dallo psicoanalista junghiano Ernst Bernhard, con la traduzione dal tedesco di Bruno Veneziani (cognato di Italo Svevo) e A.G. Ferrara.
La traduzione di Richard Wilhelm, pur godendo di straordinaria diffusione internazionale, non fu esente da critiche nel mondo accademico della sinologia. Le obiezioni riguardavano non solo specifiche scelte lessicali, ma l'intero impianto interpretativo dell'opera.
Wilhelm basò il suo lavoro principalmente sulle interpretazioni ortodosse (Chou), perpetuando una visione dell'I Ching ancorata alla tradizione Sung, piuttosto che esplorare letture alternative. Ancora, nel tentativo di rendere il testo accessibile al pubblico occidentale, Wilhelm introdusse concetti religiosi occidentali estranei al pensiero cinese originale.
Tuttavia, è innegabile che Wilhelm abbia saputo interpretare e rispondere efficacemente allo spirito del suo tempo in Occidente. La sua traduzione emerse durante un periodo di profonda disillusione verso le tradizioni occidentali e crescente fascino per la "saggezza orientale". Wilhelm rispose a questa esigenza culturale creando connessioni tra l'I Ching e la filosofia tedesca di Kant e Goethe, la tradizione biblica e la nascente psicologia analitica, costruendo così un ponte tra due mondi spirituali che rifletteva perfettamente la ricerca esistenziale dell'epoca. Le sue interpretazioni rivelano tanto dell'autore e del suo contesto storico quanto del testo stesso, rappresentando non solo un'eccellente traduzione ma anche una preziosa rielaborazione culturale che, nonostante i limiti filologici e la dipendenza dal tradizionalista Lao Nai-hsuan, seppe dialogare profondamente con le inquietudini esistenziali dell'Occidente.
Nino Iorfino